Indice
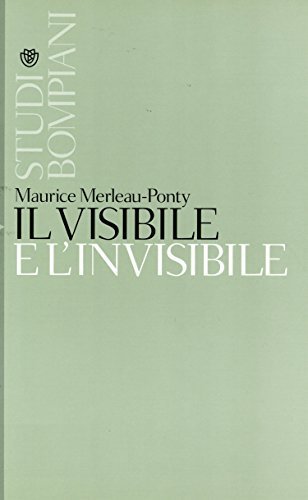
Il Visibile e l’Invisibile
“Nessuna cosa, nessun lato della cosa si mostra se non nascondendo attivamente gli altri, denunciandone l’esistenza nell’atto di nasconderli. Vedere è, per principio, vedere più di quanto si veda, accedere a un essere di latenza. L’invisibile è il rilievo e la profondità del visibile, e il visibile non comporta positività pura più dell’invisibile”.
Noi vediamo le cose stesse, il mondo è ciò che noi vediamo: formule di questo genere esprimono una fede che è comune all’uomo naturale e al filosofo dacché egli apre gli occhi, rinviano a un sostrato profondo di “opinioni” mute implicate nella nostra vita. Ma tale fede ha questo di strano, che se si cerca di articolarla in tesi o enunciato, se ci si chiede che cos’è noi, che cos’è vedere e che cos’è cosa o mondo, si entra in un labirinto di difficoltà e di contraddizioni.
Se il filosofo interroga e dunque finge di ignorare il mondo e la visione del mondo che sono operanti e si fanno continuamente in lui, è proprio per farli parlare, poiché ci crede e attende da essi tutta la sua futura scienza.
noi non sapremmo nemmeno che cosa è il falso, se qualche volta non l’avessimo distinto dal vero.
per poter parlare di falsità, dobbiamo pur avere delle esperienze della verità.
se possiamo perdere i nostri punti di riferimento a nostra insaputa, noi non siamo mai sicuri di averli quando crediamo di averli. Se, senza saperlo, possiamo ritirarci dal mondo della percezione, nulla ci dimostra che noi vi siamo mai, né che l’osservabile lo sia mai completamente, né che sia fatto di un tessuto diverso da quello del sogno; poiché la differenza tra di essi non è assoluta, si è autorizzati ad annoverarli insieme fra le “nostre esperienze”, ed è al di sopra della percezione stessa che dobbiamo cercare la garanzia e il senso della sua funzione ontologica.
come se la mia visione del mondo stesso si facesse da un certo punto del mondo.
come se l’accesso al mondo non fosse che l’altra faccia di un ritiro, e questo ritiro in margine al mondo una schiavitù e un’altra espressione del mio potere naturale di entrarvi. Il mondo è ciò che io percepisco, ma la sua prossimità assoluta, dacché la si esamina e la si esprime, diviene anche, inspiegabilmente, distanza irrimediabile.
nel momento in cui giunge la percezione, il corpo si cancella di fronte a essa, ed essa non lo coglie mai nell’atto di percepire.
mio corpo non percepisce, ma è come costruito attorno alla percezione che si fa strada attraverso di esso;
noi vediamo veramente la stessa cosa e la cosa stessa - e in pari tempo non raggiungo mai il vissuto dell’altro. È nel mondo che noi ci raggiungiamo. Ogni tentativo per restituire l’illusione della “cosa stessa” è in realtà un tentativo per ritornare al mio imperialismo e al valore della mia cosa. Esso non ci fa quindi uscire dal solipsismo: ne è una nuova prova. C) Conseguenze: profonda oscurità dell’idea naturale di verità o “mondo intelligibile”.
noi vediamo veramente la stessa cosa e la cosa stessa - e in pari tempo non raggiungo mai il vissuto dell’altro. È nel mondo che noi ci raggiungiamo. Ogni tentativo per restituire l’illusione della “cosa stessa” è in realtà un tentativo per ritornare al mio imperialismo e al valore della mia cosa. Esso non ci fa quindi uscire dal solipsismo: ne è una nuova prova.
venendo da non so quale doppio fondo dello spazio, un altro mondo privato traspare attraverso il tessuto del mio, e per un momento è in esso che vivo, io non sono più se non colui che risponde a questa sollecitazione fattami.
come abbiamo visto, la cosa stessa è sempre, per me, la cosa che io vedo. L’intervento dell’altro non risolve il paradosso interno della mia percezione: vi aggiunge questo nuovo enigma della propagazione nell’altro della mia vita più segreta - nuovo e medesimo, giacché, con ogni evidenza, è solo grazie al mondo che io posso uscire da me. E dunque ben vero che i “mondi privati” comunicano, che ciascuno di essi si dà al suo titolare come variante di un mondo comune. La comunicazione fa di noi i testimoni di un unico mondo, così come la sinergia dei nostri occhi li fa dipendere da una cosa unica. Ma in entrambi i casi la certezza, per irresistibile che sia, rimane assolutamente oscura; noi possiamo viverla, non possiamo né pensarla, né formularla, né erigerla a tesi. Ogni tentativo di delucidazione ci riconduce ai dilemmi. Ora, questa certezza ingiustificabile di un mondo sensibile che ci sia comune è in noi il sostrato della verità.
Per lo meno, il mio mondo privato ha cessato di appartenere soltanto a me, ora esso è lo strumento che un altro modula, la dimensione di una vita generalizzata che si è innestata sulla mia. Ma nell’istante stesso in cui credo di condividere la vita dell’altro, io non la raggiungo se non nei suoi fini, nei suoi poli esteriori.
Il fanciullo comprende molto di più di ciò che sa dire, risponde molto di più di ciò che egli potrebbe definire, e lo stesso può dirsi dell’adulto.
Un colloquio autentico mi fa accedere a pensieri di cui io non mi sapevo, di cui non ero capace, e talvolta io mi sento seguito in un cammino ignoto a me stesso e che il mio discorso, rilanciato dall’altro, sta aprendomi.
il mondo si chiuderà su se stesso e, tranne ciò che, in noi, pensa, e fa la scienza, tranne lo spettatore imparziale che ci abita, noi saremo divenuti parti o momenti del Grande Oggetto.
Se diamo a questa formula il valore di un Sapere assoluto, se vi cerchiamo, per esempio, il senso ultimo ed esaustivo del tempo e dello spazio, è perché l’operazione pura della scienza riprende qui a proprio profitto la nostra certezza, molto più vecchia e molto meno chiara di essa, di accedere “alle cose stesse” o di avere sul mondo un potere di sorvolo assoluto.
Ciò che il filosofo può notare - ciò che è per lui motivo di riflessione -, è che proprio quei fisici i quali conservano una rappresentazione cartesiana11 del mondo parlano delle loro “preferenze” come un musicista o un pittore parlerebbe delle sue preferenze per uno stile.
la fisica intende dire ciò che è, ma allora essa non è più autorizzata, oggi, a definire l’Essere mediante l’Essere-oggetto, né a relegare il vissuto nell’ordine delle nostre “rappresentazioni” e nel settore delle curiosità “psicologiche”; essa deve riconoscere come legittima una analisi dei processi in virtù dei quali l’universo delle misure e delle operazioni si costituisce a partire dal mondo vissuto considerato come sorgente, eventualmente come sorgente universale. In mancanza di questa analisi, in cui siano riconosciuti il diritto relativo e i limiti dell’oggettivazione classica, una fisica che conservasse tale e quale l’impianto filosofico della scienza classica e proiettasse nell’ordine del sapere assoluto i suoi propri risultati, vivrebbe, come la fede percettiva da cui esso procede, in stato di crisi permanente.
equivale a postulare che ciò che è non è ciò a cui noi siamo aperti, ma solo ciò su cui possiamo operare; e Einstein non nasconde che questa certezza di una adequazione fra l’operazione di scienza e l’Essere è in lui anteriore alla sua fisica. Egli sottolinea anzi con humour il contrasto fra la sua scienza “selvaggiamente speculativa” e la sua rivendicazione, per essa, di una verità in sé. Dovremo mostrare come l’idealizzazione fisica oltrepassi e dimentichi la fede percettiva
La critica dell’introspezione distoglie troppo spesso da questa maniera insostituibile di accedere all’altro, così come è implicato in noi. E per contro, di per se stesso il ricorso all’”esterno” non dà nessuna garanzia contro le illusioni dell’introspezione, dà solo un altro volto alla nostra idea confusa di una “visione” psicologica: non fa altro che trasportarla dall’interno all’esterno.
E proprio lo psichismo, in me, che si preoccupa di conoscere se stesso, ma c’è in esso come una vocazione continuamente mancata: in che modo una cosa potrebbe conoscersi?
Lo “psichismo” è opaco a se stesso e non si coglie se non nelle sue riproduzioni esteriori, di cui, in ultima analisi, si accerta che gli assomiglino, così come l’anatomista si accerta di trovare nell’organo che egli seziona la struttura stessa dei suoi propri occhi: c’è infatti una “specie uomo”… Una esplicitazione completa dell’atteggiamento psicologico e dei concetti di cui lo psicologo si serve come se fossero ovvi, metterebbe a nudo, in questo atteggiamento, una moltitudine di conseguenze senza premesse, un lavoro costitutivo molto vecchio che non è messo in chiaro e i cui risultati vengono accettati così come sono senza che nemmeno si sospetti fino a che punto sono confusi.
Ciò che opera qui è sempre la fede percettiva nelle cose e nel mondo. La convinzione che essa ci dà di cogliere - grazie a un sorvolo assoluto - ciò che è, noi l’applichiamo sia all’uomo che alle cose: ecco perché pensiamo l’invisibile dell’uomo come una cosa.
viene un momento in cui lo sviluppo stesso del sapere rimette in questione lo spettatore assoluto sempre presupposto. Dopo tutto, quel fisico di cui parlo e al quale attribuisco un sistema di riferimento è anche il fisico che parla. Dopo tutto, quello psichismo di cui parla lo psicologo è anche il suo psichismo. Questa fisica del fisico, questa psicologia dello psicologo, annunciano che ormai, per la scienza stessa, Tessere-oggetto non può più essere Tessere-stesso: “oggettivo” e “soggettivo” sono riconosciuti come due ordini costruiti affrettatamente all’interno di una esperienza totale di cui si dovrebbe, in tutta chiarezza, restituire il contesto.
Tra la strada lontana e quella vicina c’è una identità e nondimeno una μετάβασις εἰς ἄλλο γένος, un passaggio dall’apparente al reale, i quali sono incommensurabili.
la strada vicina non è “più vera”: il vicino, il lontano, l’orizzonte formano sistema nel loro indescrivibile contrasto, e la verità percettiva è costituita dal loro rapporto nel campo totale.
il “condizionato” condiziona qui la condizione. Certamente, un mondo percepito non apparirebbe al tale uomo se queste condizioni non fossero date nel suo corpo: ma non sono esse a spiegarlo.
mostrare che Tessere-oggetto, e in egual modo Tessere-soggetto, concepito in opposizione a esso e relativamente a esso, non costituiscono una alternativa, che il mondo percepito è al di qua o al di là dell’antinomia, che il fallimento della psicologia “oggettiva” è da comprendere - congiuntamente con il fallimento della fisica “oggettivistica” - non come una vittoria dell’interiore” sull’esteriore”, e del “mentale” sul “materiale”, ma come un invito alla revisione della nostra ontologia, al riesame delle nozioni di “soggetto” e “oggetto”.
Le stesse ragioni che impediscono di trattare la percezione come un oggetto, impediscono altresì di trattarla come l’operazione di un “soggetto”, in qualsiasi senso la si assuma
noi abbiamo confinato il magico nella soggettività, ma nulla ci garantisce che il rapporto fra gli uomini non comporti inevitabilmente delle componenti magiche e oniriche.
prendere il pensiero “oggettivo” per ciò che è: ossia come un metodo che ha fondato la scienza e che deve essere impiegato senza restrizione, fino al limite del possibile, ma che, per quanto concerne la natura, e a maggior ragione la storia, rappresenta una prima fase di eliminazione12 piuttosto che un mezzo di spiegazione totale.
le leggi di dipendenza funzionale sono un modo di circoscrivere l’irrazionale piuttosto che di eliminarlo, delle società che studia la psicologia darà solamente una veduta astratta e superficiale rispetto a quella che può offrire la storia, ed effettivamente è ciò che accade spesso.
Non appena si cessa di pensare la percezione come l’azione del puro oggetto fisico sul corpo umano e il percepito come il risultato “interiore” di questa azione sembra che si disgreghi ogni distinzione del vero e del falso, del sapere metodico e dei fantasmi, della scienza e dell’immaginazione.
porre, anche a proposito del corpo umano, il problema di sapere se esso è un oggetto e, contemporaneamente, quello di sapere se esso è, con la natura esterna, nel rapporto funzione-variabile.
Ci si impone quindi il compito di comprendere se, e in che senso, ciò che non è natura forma un “mondo”, di comprendere anzitutto che cos’è un “mondo” e infine, se c’è mondo, quali possano essere i rapporti del mondo visibile e del mondo invisibile. Per difficile che sia, questo lavoro è indispensabile se dobbiamo uscire dalla confusione in cui ci lascia la filosofia degli scienziati. Esso non può essere compiuto per intero da loro, perché il pensiero scientifico si muove nel mondo e lo presuppone più di quanto lo assuma come tema. Ma tale lavoro non è estraneo alla scienza, non ci installa fuori del mondo. Quando, con altri filosofi, diciamo che gli stimoli della percezione non sono le cause del mondo percepito, che ne sono piuttosto i rivelatori o gli attivatori, noi non vogliamo dire che si può percepire senza corpo, ma viceversa che si deve riesaminare la definizione del corpo come oggetto puro per comprendere come esso può essere il nostro legame vivente con la natura; non ci stabiliamo in un universo di essenze, chiediamo invece che si ri-consideri la distinzione del that e del what, dell’essenza e delle condizioni d’esistenza, riportandosi all’esperienza del mondo che la precede.
filosofia è l’insieme delle domande in cui colui che interroga è anch’esso chiamato in causa dalla domanda
una fisica che ha imparato a situare fisicamente il fisico e una psicologia che ha imparato a situare lo psicologo nel mondo socio-storico hanno perduto l’illusione del sorvolo assoluto: non solo esse tollerano, ma impongono l’esame radicale della nostra appartenenza al mondo prima di ogni scienza.
I metodi di prova e di conoscenza, che un pensiero già installato nel mondo inventa, i concetti d’oggetto e di soggetto che esso introduce, non ci permettono di comprendere che cos’è la fede percettiva, proprio perché essa è una fede, cioè una adesione che si sa al di là delle prove, non necessaria, intessuta di incredulità, in ogni momento minacciata dalla non-fede. La credenza e l’incredulità sono qui così strettamente collegate che troviamo sempre l’una nell’altra, e in particolare un germe di non-verità nella verità: la certezza che io ho di essere innestato sul mondo mediante il mio sguardo mi promette già uno pseudo-mondo di fantasmi, se lascio errare questo sguardo. Nascondersi gli occhi per non vedere un pericolo è, si dice, non credere alle cose, credere soltanto al mondo privato. Significa invece credere che ciò che è per noi è assolutamente, che un mondo che noi siamo riusciti a vedere senza pericolo è senza pericolo, e dunque credere nel modo più intenso che la nostra visione va alle cose stesse. Forse questa esperienza ci insegna meglio di qualsiasi altra che cos’è la presenza percettiva del mondo: non, ciò che sarebbe impossibile, affermazione e negazione della stessa cosa sotto lo stesso rapporto, giudizio positivo e negativo, o, come dicevamo prima, credenza e incredulità; al di qua dell’affermazione e della negazione, al di qua del giudizio - opinioni critiche, operazioni ulteriori, - essa è la nostra esperienza, più vecchia di qualsiasi opinione, di abitare il mondo mediante il nostro corpo, la verità con tutti noi stessi, senza che ci sia da scegliere e nemmeno da distinguere tra la certezza di vedere e quella di vedere il vero, poiché essi sono per principio una medesima cosa, - fede, dunque, e non sapere, perché il mondo non è qui separato dalla nostra presa su di esso, perché, più che affermato, esso è assunto come ovvio e, più che svelato, è non-dissimulato, non confutato.
E necessario che il filosofo comprenda come queste due possibilità, che la fede percettiva conserva in se stessa a fianco a fianco, non si annullino. Egli non ci riuscirà se si mantiene al loro livello, oscillando dall’una all’altra, dicendo di volta in volta che la mia visione inerisce alla cosa stessa e che la mia visione è mia o “in me”. Bisogna che egli rinunci a queste due vedute, che si astenga tanto dall’una quanto dall’altra, che non soggiaccia a esse, giacché sono incompossibili nella loro letteralità, ma si richiami a se stesso, il quale ne è il titolare e deve quindi sapere che cosa le motiva dall’interno, che le perda come stato di fatto per ricostruirle come possibilità sue, per imparare da sé ciò che esse significano in verità, ciò che lo destina sia alla percezione, sia ai fantasmi: in breve, bisogna che egli rifletta
Orbene, non appena lo fa, al di là del mondo stesso e al di là di ciò che è soltanto “in noi”, al di là dell’essere in sé e dell’essere per noi, sembra aprirsi una terza dimensione, in cui la loro discordanza scompare.
percepire e immaginare non sono più se non due modi di pensare.
è ben vero che noi percepiamo la cosa stessa - giacché la cosa non è altro che ciò che noi vediamo -, ma non la percepiamo in virtù del potere occulto dei nostri occhi: essi non sono più soggetti della visione, sono passati nel novero delle cose viste, e ciò che si chiama visione dipende dalla potenza di pensare, la quale attesta che l’apparenza ha qui risposto secondo una regola ai movimenti dei nostri occhi.
La percezione, quando è piena o attuale, è il pensiero di percepire.
io non credo più di vedere con i miei occhi delle cose esteriori a me che le vedo: esse sono esteriori solo al mio corpo, non al mio pensiero, che lo sorvola così come sorvola le cose. E non mi lascio impressionare neanche dall’evidenza che gli altri soggetti percipienti non vanno alle cose stesse, che la loro percezione si svolge in essi, - evidenza che finisce per ripercuotersi sulla mia propria percezione, giacché, in definitiva, ai loro occhi, io sono un “altro”, e il mio dogmatismo, comunicandosi agli altri, rimbalza su di me come scetticismo -; infatti, se è vero che, vista dall’esterno, - la percezione di ciascuno sembra rinchiusa in qualche recesso, “dietro” il suo corpo, questa veduta esteriore è appunto annoverata dalla riflessione fra i fantasmi senza consistenza e i pensieri confusi: non pensiamo un pensiero dall’esterno, per definizione il pensiero si pensa solo intrinsecamente; se gli altri sono dei pensieri, non sono, a questo titolo, dietro il loro corpo che io vedo, non sono, come me, in nessun luogo; come me, essi sono coestensivi all’essere, e non c’è un problema dell’incarnazione.
nel cuore di tutti i pensieri situati, affondati e incarnati abbiamo riconosciuto, attraverso la riflessione, il puro apparire del pensiero a se stesso, l’universo dell’adequazione interna, in cui tutto ciò che abbiamo di vero si integra senza difficoltà…
Senza neanche presumere di sapere tutto da me stesso, è almeno certo che, fra l’altro, io sono sapere, questo attributo mi appartiene sicuramente, anche se ne ho altri. Io non posso immaginare che il mondo faccia irruzione in me o io in esso: a questo sapere che io sono il mondo può presentarsi solo offrendogli un senso, solo sotto forma di pensiero del mondo. Il segreto del mondo che noi cerchiamo deve necessariamente essere contenuto nel mio contatto con esso. Di tutto ciò che io vivo, in quanto lo vivo, io ho presso di me il senso, altrimenti non lo vivrei, e non posso cercare nessuna luce concernente il mondo se non interrogando, esplicitando la mia frequentazione del mondo, comprendendola dall’interno
è essenziale rifare, partendo da noi, un cammino già tracciato da questo centro a noi: lo sforzo stesso verso l’adequazione interna, l’impresa di riconquistare esplicitamente tutto ciò che noi siamo e facciamo implicitamente, significa che ciò che siamo infine come naturati, noi lo siamo dapprima attivamente come naturanti, che il mondo è il nostro luogo natale solo perché, come spiriti, noi siamo originariamente la culla del mondo.
la riflessione recupera tutto salvo se stessa come sforzo di recupero, illumina tutto tranne la sua propria funzione. Anche l’occhio dello spirito ha il suo punto cieco, ma, poiché è spirito, non può ignorarlo, né trattare come un semplice stato di non-visione, che non esige nessuna menzione particolare, l’atto stesso di riflessione che è quoad nos il suo atto di nascita. Se non ignora se stessa -ciò che contrasterebbe con la sua definizione -, la riflessione non può fingere di svolgere lo stesso filo che lo spirito avrebbe dapprima avvolto, d’essere lo spirito che, in me, ritorna a sé, quando per definizione sono io a riflettere; essa deve apparire a se stessa come cammino verso un soggetto X, appello a un soggetto X. La sua stessa certezza di raggiungere un naturante universale, non potendole venire da qualche contatto preliminare con quest’ultimo - perché appunto la riflessione è ancora ignoranza, perché lo evoca e non coincide con esso - può allora venirle solo dal mondo o dai miei pensieri in quanto formano un mondo, in quanto la loro coesione, le loro linee di fuga designano al di qua della riflessione stessa un nucleo virtuale con il quale io non coincido ancora.
Tutta l’analisi riflessiva non è falsa, bensì ingenua, finché nasconde a se stessa il suo proprio movente e il fatto che, per costituire il mondo, è necessario avere nozione del mondo in quanto precostituito, ragion per cui il procedimento è per principio in ritardo su se stesso.
Le osservazioni che facevamo sulla riflessione non erano affatto destinate a squalificarla a beneficio dell’irriflesso o dell’immediato (che noi conosciamo solo attraverso di essa). Non si tratta di sostituire alla riflessione la fede percettiva, ma viceversa di tener conto della situazione totale, che comporta il rinvio dall’una all’altra.
una riflessione che si volge sullo spessore del mondo per rischiararlo, ma che, a cose fatte, non gli rinvia se non la sua propria luce.
Io vedo, sento, ed è certo che, per rendermi conto di che cos’è vedere e sentire, devo cessare di accompagnare il vedere e il sentire nel visibile e nel sensibile in cui si gettano, e riservare, al di qua di essi stessi, un ambito che non occupano e dal quale divengono comprensibili secondo il loro senso e la loro essenza. Comprenderli è sospenderli, perché la visione ingenua mi occupa per intero, perché l’attenzione alla visione che vi si aggiunge toglie qualcosa a questo dono totale, e soprattutto perché comprendere è tradurre in significati disponibili un senso dapprima prigioniero nella cosa e nel mondo stesso.
intravediamo la necessità di una specie di superriflessione che tenga conto anche di se stessa e dei mutamenti che essa introduce nello spettacolo, che quindi non perda di vista la cosa e la percezione grezze, e che infine non le cancelli, non recida, attraverso una ipotesi di inesistenza, i legami organici della percezione e della cosa percepita, e assuma viceversa il compito di pensarli, di riflettere sulla trascendenza del mondo come trascendenza, di parlarne non secondo la legge dei significati delle parole, inerenti al linguaggio dato, ma grazie a uno sforzo, forse difficile, che impiega questi significati per esprimere, al di là dei significati stessi, il nostro contatto muto con le cose, quando esse non sono ancora cose dette.
Se quindi la riflessione non deve presumere di ciò che trova e condannarsi a mettere nelle cose ciò che poi fingerà di trovarvi, è necessario che essa non sospenda la fede nel mondo se non per vederlo e per leggere nel mondo il cammino che esso ha seguito divenendo mondo per noi, che cerchi nel mondo stesso il segreto del nostro legame percettivo con esso, che impieghi le parole per dire questo legame prelogico, e non conformemente al loro significato prestabilito, che si immerga nel mondo anziché dominarlo, che discenda verso di esso così come è anziché risalire verso una possibilità preliminare di pensarlo - la quale gli imporrebbe anticipatamente le condizioni del nostro controllo su di esso -, che lo interroghi, che entri nella selva dei riferimenti che la nostra interrogazione fa sorgere in esso, che gli faccia dire, infine, ciò che nel suo silenzio esso vuole dire… Noi non sappiamo né che cos’è esattamente questo ordine e questa concordanza del mondo a cui ci affidiamo così, né quindi a che cosa metterà capo l’impresa, né se essa è veramente possibile. Ma la scelta è fra questa impresa e un dogmatismo della riflessione di cui conosciamo fin troppo bene l’esito, giacché con tale dogmatismo la filosofia si compie nel momento in cui comincia e, appunto per questa ragione, non ci fa comprendere la nostra propria oscurità.
“reale” e l’immaginario” sono due “ordini”, due “scene” o due “teatri” (quello dello spazio e quello dei fantasmi) allestiti in noi prima degli atti di discriminazione che non intervengono se non nei casi equivoci,
Se lo facciamo, non si dovrà quindi definire il reale per la sua coerenza e l’immaginario per la sua incoerenza o le sue lacune: il reale è coerente e probabile perché è reale, e non reale perché è coerente; l’immaginario è incoerente o improbabile perché è immaginario, e non immaginario perché è incoerente. La più piccola particella del percepito incorpora subito quest’ultimo al “percepito”, il fantasma più verosimile scivola alla superficie del mondo; è tale presenza del mondo intero a un riflesso, la sua irrimediabile assenza nei deliri più ricchi e più sistematici che dobbiamo comprendere, e la differenza non è semplicemente di grado.
La disillusione è la perdita di un’evidenza solo perché è l’acquisizione di un’altra evidenza.
forse la “realtà” non appartiene definitivamente a nessuna percezione particolare e che sempre, in questo senso, essa è più lontano: ma ciò non mi autorizza a rompere o a passare sotto silenzio il legame che, una dopo l’altra, riunisce le percezioni al reale e che non può essere rotto con una di esse senza prima essere stabilito con quella successiva,
il “probabile” evoca una esperienza definitiva del “reale” la cui scadenza è solamente differita.
Ogni percezione è mutevole e solamente probabile; se si vuole, non è che un’opinione; ma ciò che non lo è, ciò che ogni percezione, anche falsa, verifica, è l’appartenenza di tutte le esperienze allo stesso mondo, il loro eguale potere di manifestarlo, essendo possibilità dello stesso mondo.
lo svolgimento del mondo era l’avvolgimento su se stesso di un pensiero che, qualsiasi cosa pensi, lo fa solo perché dapprima si pensa.
C’è preesistenza del mondo alla nostra percezione, degli aspetti del mondo che l’altro percepisce alla percezione che io ne avrò in seguito, del mio mondo a quello degli uomini che nasceranno, e tutti questi “mondi” formano un mondo unico, ma solamente in ciò: che le cose e il mondo sono degli oggetti di pensiero con le loro proprietà intrinseche, che appartengono all’ordine del vero, del valido, del significato, e non all’ordine dell’evento. Il problema di sapere se il mondo è unico per tutti i soggetti perde ogni significato una volta ammessa l’idealità del mondo; chiedere se il mio mondo e quello altrui sono il medesimo numericamente o specificamente non significa più nulla, giacché, in quanto struttura intelligibile, il mondo è sempre al di là dei miei pensieri come eventi, ma anche al di là di quelli degli altri, cosicché esso non è diviso dalla conoscenza che noi ne abbiamo, e non è nemmeno unico nel senso in cui lo è ciascuno di noi. In tutto ciò che significano, la mia percezione e la percezione che un altro uomo ha del mondo sono la medesima, quantunque le nostre vite non siano commensurabili, perché il significato, il senso, essendo adequazione interna, rapporto di sé a sé, interiorità pura e al tempo stesso apertura totale, non discendono mai in noi come assoggettati a una prospettiva, perché, a questo titolo, noi non siamo la luce che ci illumina, e perché tutte le nostre verità si riuniscono quindi spontaneamente in quanto verità e formano di diritto un unico sistema.
rientrare in sé è anche uscire da sé.
Affinché io sia in e-stasi nel mondo e nelle cose, è necessario che niente mi trattenga in me stesso lontano da esse: nessuna “rappresentazione”, nessun “pensiero”, nessuna “immagine”, e nemmeno quella qualificazione di “soggetto”, di “spirito” o di “Ego”, in virtù della quale il filosofo vuole distinguermi assolutamente dalle cose, ma che a sua volta diviene ingannevole giacché, come ogni designazione, essa finisce per ricadere nel positivo, per reintrodurre in me un fantasma di realtà e per farmi credere che io sono res cogitans, - una cosa molto particolare, inafferrabile, invisibile, ma pur sempre cosa.
L’unico modo di assicurare il mio accesso alle cose stesse sarebbe quello di purificare completamente la mia nozione della soggettività: anzi, non c’è “soggettività”, o “Ego”, la coscienza è senza “abitante”, è necessario che io la sciolga completamente dalle appercezioni seconde che fanno di essa il rovescio di un corpo, la proprietà di uno “psichismo” e che io la scopra come il “niente”, il “vuoto”, che è capace della pienezza del mondo, o meglio, che ne ha bisogno per sorreggere la sua inanità.
perché questa negazione non svanisca in pura esteriorità, -e con essa ogni possibilità di negazione in generale, - il suo fondamento deve trovarsi nella necessità per l’essere che manca di… d’essere ciò che gli manca. Così il fondamento della negazione è negazione della negazione.
il Per-sé è presenza immediata all’essere, e insieme scivola come una distanza infinita tra se stesso e l’essere
la coscienza esistente è sempre satura di qualità, sprofondata nell’essere che essa nullifica e sul quale non ha, per così dire, nessun potere motorio, essendo di un altro ordine. La mia autoapprensione è coestensiva alla mia vita come sua possibilità di principio, o, più esattamente, è questa possibilità che è me, io sono questa possibilità, e, grazie a essa, tutte le altre; ma è una possibilità di nullificazione, essa lascia intatta l’attualità assoluta del mio essere incarnato come quella di ogni essere, l’opacità della mia vita, finché non mi applico a essa per riflessione; e, in quanto esperienza del mio essere, il cogito è cogito preriflessivo, non pone questo essere come oggetto davanti a me; per posizione, e prima di ogni riflessione, io mi tocco attraverso la mia situazione, è a partire da essa che sono rinviato a me, io mi ignoro come nulla, non credo che alle cose. Appunto perché, in ciò che ho di più proprio, io non sono niente, niente mi separa mai da me stesso, ma d’altro canto niente mi segnala a me stesso, e io sono in e-stasi nelle cose.
a questo mondo che non è me io inerisco altrettanto strettamente che a me stesso, in un certo senso esso non è se non il prolungamento del mio corpo;10 sono autorizzato a dire che io sono il mondo.
essere non è rimanere nell’identità, ma portare davanti a me l’identificabile, ciò che c’è, a cui io non aggiungo altro che la piccola appendice “così come è”, - e nondimeno questo passaggio dall’essere grezzo all’essere avverato o alla sua verità è richiesto, dal fondo dell’essere esteriore, dalla sua qualità stessa di esteriore, nello stesso tempo in cui la negazione radicale che io sono chiede di negare se stessa.
Tutto ciò che è parziale è da reintegrare, ogni negazione è in realtà determinazione, e l’essere-sé, l’essere-altro, l’essere in sé sono frammenti di un solo essere.
scopriamo al centro delle cose che gli opposti sono a tal punto esclusivi che, se non si implicassero vicendevolmente, sarebbero solo astrazione, che la forza dell’essere si appoggia sulla debolezza del nulla che è suo complice, che l’oscurità dell’In Sé è tale per la chiarezza del Per Sé in generale, se non per quella della “mia coscienza”. Il celebre problema ontologico, il “perché c’è qualcosa anziché niente?” scompare con l’alternativa: non c’è qualcosa anziché niente, il niente non potrebbe prendere il posto del qualcosa o dell’essere: il nulla inesiste (nel senso negativo) e l’essere è, e il loro combaciare dissolve ogni problema.
Tutto è oscuro quando non si è pensato il negativo, tutto è chiaro quando lo si è pensato come negativo.
l’ampiezza dell’essere non oltrepasserà mai quella del nulla, né il rumore del mondo il suo silenzio.
Pensando a partire dal negativo puro, si decide già di pensare secondo l’identità, si è già nell’identità, giacché questo negativo, che niente può limitare nel suo ordine, dovendo andare sino in fondo a se stesso, sarà anche e fondamentalmente autonegazione, e quindi si pronuncerà sotto forma di un avvento dell’essere puro.
se diciamo che il negativo è, ne distruggiamo la negatività, ma se teniamo per fermo che esso non è, allora lo innalziamo ancora a una specie di positività, gli conferiamo una specie d’essere, giacché, da capo a fondo e assolutamente, esso è niente.
questo essere, per essere positivo e pieno, deve essere piatto, e quindi resta ciò che è, al di là dell’ambivalenza in cui ci troviamo confinati
Io vengo risucchiato da me stesso per opera dello sguardo dell’altro, ma il suo potere su di me è esattamente commisurato al consenso che io ho dato al mio corpo, alla mia situazione, egli non ha forza alienante se non perché io mi alieno spontaneamente.
L’altro è una delle forme empiriche dello sprofondamento nell’Essere…
nella misura in cui è vero che io non sono niente, l’altro può apparirmi soltanto così, come l’ultra-mondo dal quale parte uno sguardo di cui io sento solamente l’impatto sul mio corpo; nella misura in cui sono un pensiero, una coscienza, io sono costretto a entrare nel mondo unicamente attraverso di essa, e le altre coscienze, gli altri pensieri, non saranno mai se non i duplicati o le sorelle minori della mia. Io non vivrò mai se non la mia vita, e gli altri non saranno mai se non degli altri me stesso.
Per pensare l’essere totale - ciò che è totalmente e quindi anche ciò a cui non manca niente, ciò che è tutto l’essere -, si deve essere fuori di esso, è necessario un margine di non-essere, ma questo margine escluso dal tutto gli impedisce di essere tutto; la vera totalità dovrebbe contenere anch’esso: ciò che è impossibile, poiché si tratta appunto di un margine di non-essere. Così, se sono assolutamente opposti, l’essere e il nulla si fondono insieme in una specie di Super-essere che è mitico, giacché la forza che l’esige è la loro assoluta repulsione.
se veramente questo contatto è ambivalente, sta a noi adeguarci, e delle difficoltà logiche non possono niente contro questa descrizione. In realtà, le definizioni dell’essere come ciò che è sotto ogni riguardo e senza restrizioni, e del nulla come ciò che non è sotto nessun riguardo, questa appropriazione da parte del pensiero di un essere immediato e di un nulla immediato, questa intuizione e questa negintuizione, sono il ritratto astratto di una esperienza, ed è sul terreno dell’esperienza che esse vanno discusse
Ho un nulla riempito dall’essere, un essere svuotato dal nulla, e, se ciò non è distruzione di ciascuno dei termini per opera dell’altro, di me per opera del mondo e del mondo per opera mia, è necessario che la nullificazione dell’essere e lo sprofondamento del nulla in esso non siano relazioni esteriori e non siano due operazioni distinte. E ciò che si tenta di ottenere pensando la visione come nullificazione. Così intesa, essa fa passare l’In Sé stesso alla condizione di mondo visto, e fa altresì passare il Per Sé alla condizione di Per Sé sprofondato nell’essere, situato, incarnato. Come nulla operante, la mia visione è presenza d’ubiquità al mondo stesso, giacché è priva di inerzia e di opacità,17 e al tempo stesso irrimediabilmente distinta da ciò che vede, da cui è separata dal vuoto stesso che le permette di essere visione.
Riusciremo a descrivere l’accesso alle cose stesse solo attraverso questa opacità e questa profondità, che non vengono mai meno: non c’è cosa pienamente osservabile, non c’è ispezione della cosa che sia senza lacune e che sia totale;
un sistema a quattro termini: il mio essere per me, il mio essere per altri, il per sé dell’altro e il suo essere per me.
apparteniamo al medesimo sistema dell’essere per sé e dell’essere per altri, siamo dei momenti della medesima sintassi, contiamo nello stesso mondo, dipendiamo dallo stesso Essere
imparando a conoscere, nella visione stessa, una specie di palpazione delle cose, e nel sorvolo stesso una inerenza.
ciò che merita il nome di essere sia non già l’orizzonte di essere “puro”, ma il sistema delle prospettive che introduce a esso, che l’essere integrale sia non davanti a me, ma all’intersezione delle mie vedute e all’intersezione delle mie vedute e di quelle degli altri, all’intersezione dei miei atti e all’intersezione dei miei atti e di quelli degli altri, che il mondo sensibile e il mondo storico siano sempre degli intermondi, perché essi sono ciò che, al di là delle nostre vedute, le rende solidali fra di esse e solidali con quelle degli altri, sono le istanze alle quali noi ci rivolgiamo non appena viviamo, i registri in cui si inscrive ciò che vediamo, ciò che facciamo, per divenirvi cosa, mondo, storia.
L’immaginario è senza consistenza, inosservabile, e svanisce quando si passa alla visione.
Negando se stesso, il negativo si sacrifica al positivo, e il positivo puro, in quanto si afferma senza restrizioni, sanziona tale sacrificio, - questo movimento dei significati, che non è altro che l’essere dell’essere e l’inesistenza del nulla seguiti nelle loro conseguenze, il principio di non contraddizione messo in pratica, fornisce lo schema di una visione pura con la quale il filosofo coincide.
vivere e pensare è sempre, come si vorrà dire, identificarsi o nullificare.
la spontaneità consiste nell’essere secondo il modo del non essere, la critica riflessiva nel non essere secondo il modo dell’essere, e perché questi due rapporti formano un circuito che è noi.
più si descrive l’esperienza come una mescolanza dell’essere e del nulla, più la loro distinzione assoluta è confermata, più il pensiero aderisce all’esperienza e più la tiene a distanza.
questo pensiero non può essere circoscritto o distinto per ciò che afferma - infatti afferma tutto -, ma solamente per ciò che esso lascia da parte appunto nella sua volontà di essere tutto: ossia la situazione del filosofo che parla come distinta da ciò di cui egli parla, in quanto essa assegna a ciò che egli dice un certo contenuto latente che non è il suo contenuto manifesto, in quanto implica uno scarto fra le essenze che egli fissa e il vissuto al quale essa si applica, fra l’operazione di vivere il mondo e le entità e le negatità nelle quali egli l’esprime.
c’è essere, c’è mondo, c’è qualcosa; nel senso forte in cui il greco parla di τὸ λέγειν, c’è coesione, c’è senso.
Ciò che è primo non è l’essere pieno e positivo sullo sfondo del nulla, ma un campo d’apparenze, ciascuna delle quali, presa a parte, forse si dissolverà, o in seguito (è la parte del nulla) sarà cancellata: tuttavia, io so soltanto che sarà sostituita da un’altra la quale sarà la verità della prima, perché c’è mondo, perché c’è qualcosa, un mondo, un qualcosa, che, per essere, non debbono anzitutto annullare il niente.
È ancora troppo dire che il nulla non è, dire che è negazione pura: ciò equivale a fissarlo nella sua negatività, a trattarla come una specie di essenza, a introdurre in essa la positività delle parole, mentre essa non può valere se non come ciò che non ha né nome, né riposo, né natura. Per principio, una filosofia del negativo non può partire dalla negazione “pura”, né fare di essa l’agente della sua propria negazione.
il cammino è fattibile facendolo,
per essere vero ogni enunciato deve essere riferito, nell’insieme del movimento, alla tappa da cui dipende, e ha il suo senso pieno unicamente se si tien conto non solo di ciò che esso dice espressamente, ma anche del suo posto nel tutto che ne costituisce il contenuto latente; così, colui che parla (e ciò che egli sottintende) codetermina sempre il senso di ciò che egli dice, il filosofo è sempre implicato nei problemi che pone, e non c’è verità se, per valutare ogni enunciato, non si tiene conto della presenza del filosofo che enuncia; fra il contenuto manifesto e il contenuto latente possono esserci non solo differenze, ma anche contraddizione, e nondimeno questo doppio senso gli appartiene - come quando vogliamo considerare una cosa in sé, e, per ciò stesso, concentrandoci su di essa, cominciamo a determinarla così come è per noi; di modo che, per il pensiero dialettico, l’idea dell’In Sé e l’idea del Per Noi hanno la loro verità ciascuna fuori di se stessa, non appartengono al pensiero totale o pieno, che si definirebbe per una esplicitazione senza limite.
per ogni termine è la stessa cosa passare nell’altro o divenire sé, uscire da sé o rientrare in sé, che il movimento centripeto e quello centrifugo sono un unico movimento, poiché ogni termine è la sua propria mediazione, l’esigenza di un divenire, e anche di una autodistruzione che mette capo all’altro.
integrare in un unico universo i doppi o anche molteplici sensi,
È quindi escluso che la mediazione abbia la sua origine nel termine positivo, come se fosse una delle sue proprietà,- ma è ugualmente escluso che essa gli giunga da un abisso di negatività esteriore, che non avrebbe presa su di esso e lo lascerebbe intatto.
la negazione è portata all’assoluto, diviene negazione di se stessa; simultaneamente, l’essere ricade nel positivo puro, la negazione si concentra al di là di esso come soggettività assoluta, e il movimento dialettico diviene identità pura degli opposti, ambivalenza.
il pensiero cessa di accompagnare o di essere il movimento dialettico, lo converte in significato, tesi, o cosa detta, e contemporaneamente ricade nell’immagine ambivalente del Nulla che si sacrifica perché l’Essere sia e dell’Essere che, dal fondo del suo primato, tollera d’essere riconosciuto dal Nulla.
non solo un rischio di non senso quindi, ma molto peggio: la certezza che le cose hanno un altro senso da quello che noi siamo in grado di riconoscere loro.
la buona dialettica è quella che è cosciente del fatto che ogni tesi è idealizzazione, che l’Essere non è fatto di idealizzazioni o di cose dette, come credeva la vecchia logica, ma di insiemi legati in cui il significato non è mai se non come tendenza, in cui l’inerzia del contenuto non permette mai di definire un termine come positivo, un altro come negativo e tanto meno un terzo termine come autosoppressione assoluta del secondo. Ecco il punto da tener presente: che la dialettica senza sintesi, di cui parliamo, non è però lo scetticismo, il relativismo volgare, o il regno dell’ineffabile. Ciò che respingiamo o neghiamo non è l’idea del superamento che riunisce, ma l’idea che esso metta capo a un nuovo positivo, a una nuova posizione.
deve ritrovare l’essere prima della scissura riflessiva, attorno a essa, nel suo orizzonte, non fuori di noi e non in noi, ma dove i due movimenti si incrociano, dove “c’è” qualcosa.
Dopo tutto le domande sorgono nel linguaggio. Anche se ci sembra che un pensiero affermativo può staccarsi dalle parole e riposare sulla sua adequazione interna, la negazione, e soprattutto l’interrogazione, che non enunciano nessuna proprietà intrinseca delle cose, possono sostenersi solo grazie all’apparato del linguaggio.
per quanto riguarda la risposta, essa può venire ricercata, così sembra, solo nelle significazioni delle parole, giacché è in parole che si risponderà alla domanda.
l’ombra è in noi piuttosto che fuori;
Dal punto di vista dell’Essere e il Nulla, l’apertura all’essere significa che io lo visito in se stesso: se esso rimane distante, è perché il nulla - l’anonimo in me che vede - dispone davanti a sé una zona di vuoto in cui l’essere non si limita più a essere, ma è visto.
questo universo che la filosofia ha di mira, e che è, come si suol dire, l’oggetto della filosofia, - ma qui la lacuna non sarà mai colmata, l’incognita non sarà mai trasformata in termine noto, l’”oggetto” della filosofia non verrà mai a riempire l’interrogativo filosofico, giacché questa otturazione lo priverebbe della profondità e della distanza che gli sono essenziali.
L’essere effettivo, presente, ultimo e primo, la cosa stessa, sono per principio colti per trasparenza attraverso le loro prospettive, si offrono quindi solo a qualcuno che vuole non già averli, ma vederli, non tenerli come in una pinza, o immobilizzarli come sotto l’obiettivo di un microscopio, ma lasciarli essere, e assistere al loro essere ininterrotto; a qualcuno che si limita a restituire loro il vuoto, lo spazio libero che essi ridomandano, la risonanza che esigono; a qualcuno, pertanto, che segue il loro proprio movimento, a qualcuno che è non già un nulla che l’essere pieno verrebbe a otturare, ma una domanda accordata all’essere poroso che essa interroga e dal quale non ottiene risposta, bensì conferma del suo stupore. Si deve intendere la percezione come questo pensiero interrogativo che lascia essere il mondo percepito anziché porlo, e di fronte al quale le cose si fanno e si disfano in una specie di slittamento, al di qua del sì o del no.
l’esame dei significati in se stessi ci darebbe il mondo ridotto alle nostre idealizzazioni e alla nostra sintassi.
le parole più pregne di filosofia non sono necessariamente quelle che racchiudono ciò che dicono, ma piuttosto quelle che mettono capo il più energicamente possibile all’Essere, poiché restituiscono più rigorosamente la vita del tutto e fanno vibrare, fino a disgiungerle, le nostre evidenze abituali.
come ogni fede, essa è fede perché è possibilità di dubbio,
Non è solamente la filosofia, ma anzitutto lo sguardo a interrogare le cose.
L’orologio e la carta geografica non le danno che una parvenza di risposta: essi ci indicano come ciò che noi stiamo vivendo si situi in rapporto al corso degli astri o a quello di una giornata umana, o in rapporto a luoghi che hanno un nome. Ma questi eventi-riferimento, e queste località, dove sono a loro volta? Ci rinviano ad altri, e la risposta ci soddisfa solo perché non vi facciamo attenzione, perché ci crediamo “a casa nostra”.
Ogni domanda, anche quella della semplice conoscenza, fa parte della domanda centrale che è noi stessi,
nell’immensa simultaneità del mondo e nella sua pulsione indivisa.
dovrebbe non più negare e nemmeno dubitare, ma solo arretrare per vedere il mondo e l’Essere, o anche metterli tra virgolette come si fa per le parole di un altro, lasciarli parlare, mettersi in ascolto…
il presente visibile non è nel tempo e nello spazio, né, naturalmente, fuori di essi: non c’è nulla prima di esso, dopo di esso, attorno a esso, che possa rivaleggiare con la sua visibilità. E tuttavia, non è solo, non è tutto. Esattamente: esso intercetta la mia veduta, vale a dire che il tempo e lo spazio si estendono al di là, e al tempo stesso che sono dietro di esso, in profondità, di nascosto. Il visibile può così riempirmi e occuparmi solo perché, io che lo vedo, non lo vedo dal fondo del nulla, ma dal cuore del visibile stesso: io, il vedente, sono anche visibile; ciò che costituisce il peso, lo spessore, la carne di ogni colore, di ogni suono, di ogni testura tattile, del presente e del mondo,
noi siamo delle esperienze, cioè dei pensieri, che sentono dietro di sé la pressione dello spazio, del tempo, dell’Essere stesso che essi pensano, che quindi non tengono sotto il loro sguardo uno spazio e un tempo seriale, né la pura idea delle serie, ma che hanno attorno a sé un tempo e uno spazio di ammucchiamento, di proliferazione, di sopravanzamento, di promiscuità, -perpetua pregnanza, perpetuo parto, generalità e generatività, essenza grezza ed esistenza grezza, che sono i ventri e i nodi della medesima vibrazione ontologica.
sarebbe ingenuo cercare la solidità in un cielo delle idee o in un fondo del senso: essa non è né al di sopra, né al di sotto delle apparenze, ma alla loro congiunzione, è il vincolo che collega segretamente una esperienza alle sue varianti.
Come il mio corpo, che è uno dei visibili, vede anche se stesso e con ciò diviene luce naturale che dischiude al visibile il suo interno, affinché esso vi diventi il mio paesaggio, e che realizza, come si suol dire, la miracolosa promozione dell’Essere alla “coscienza”, o, come preferiamo dire, la segregazione dell’”interno” e dell’”esterno”, - così la parola
La parola è parte totale delle significazioni come la carne del visibile, come essa è rapporto all’Essere attraverso un essere, e come essa, infine, è narcisistica, erotizzata, dotata di una magia naturale che attira nella sua rete le altre significazioni nello stesso modo in cui il corpo sente il mondo sentendosi.
Come il mondo è dietro il mio corpo, così l’essenza operante è dietro la parola operante, quella che, più che possedere il significato, è da esso posseduta, che non ne parla, ma lo parla, o parla in base a esso, o lo lascia parlare e parlarsi in me, attraversa il mio presente.
Sia nella discussione o nel monologo, l’essenza allo stato vivente e attivo è sempre un certo punto di fuga indicato dall’assetto delle parole, il loro “altro lato”, inaccessibile, salvo per colui che accetta di vivere dapprima e sempre in esse.
La peculiarità dell’interrogazione filosofica è di volgersi su se stessa, di chiedersi anche che cos’è interrogare e che cos’è rispondere.
Dicevamo che il dubbio è un positivismo clandestino, e che lo si deve superare verso il qualcosa che esso nega e afferma anche. Ma reciprocamente, se lo si volesse superare verso una sfera di assoluta certezza che fosse quella dei significati o delle essenze, questo positivismo assoluto vorrebbe dire che chi interroga ha talmente allontanato da sé l’Essere e il mondo che non ne fa più parte.
Interrogarsi sull’essenza del tempo e dello spazio non è ancora fare della filosofia, se in seguito non ci si interroga sui rapporti del tempo stesso e dello spazio stesso con la loro essenza.
dell’interrogazione come rapporto ultimo all’Essere e come organo ontologico.
Al momento di divenire percezione pura, cosa, Essere, la mia percezione si spegne; nel momento in cui essa si accende, io non sono già più la cosa. E parimenti, nei confronti dell’essere del passato non c’è coincidenza reale: se il ricordo puro è il vecchio presente conservato, e se, nella rimemorazione, io ridivengo veramente ciò che fui, non si vede come essa potrebbe dischiudermi la dimensione del passato; e se, inscrivendosi in me, ogni presente perde la sua carne, se il ricordo puro nel quale esso si tramuta è un invisibile, allora c’è sì passato, ma non coincidenza con esso, io ne sono separato da tutto lo spessore del mio presente,
Come non c’è mai contemporaneamente cosa e coscienza della cosa, così non c’è mai contemporaneamente passato e coscienza del passato, e per lo stesso motivo: in una intuizione per coincidenza e fusione, tutto ciò che si dà all’Essere è tolto all’esperienza, tutto ciò che si dà all’esperienza è tolto all’Essere.
io e il mondo siamo l’uno nell’altro, e dal percipere al percipi non c’è anteriorità, ma simultaneità o addirittura ritardo.
miei occhi che vedono, le mie mani che toccano possono essere anche visti e toccati, poiché quindi, in questo senso, essi vedono e toccano dal di dentro il visibile e il tangibile,
le cose passano in noi nello stesso modo in cui noi passiamo nelle cose.
Se la coincidenza è sempre e solo parziale, non si deve definire la verità con la coincidenza totale o effettiva. E se abbiamo l’idea della cosa stessa e del passato stesso, è necessario che essa abbia qualche rispondenza nel fatto. Occorre quindi che lo scarto, senza il quale l’esperienza della cosa o del passato si ridurrebbe a zero, sia anche apertura alla cosa stessa o al passato stesso ed entri nella loro definizione.
Allora, ciò che è dato non è la cosa nuda, il passato stesso così come fu a suo tempo, ma la cosa pronta a essere vista, pregna, sia per principio che di fatto, di tutte le visioni che è possibile averne, il passato così come fu un giorno, più una inspiegabile alterazione, una strana distanza, - collegato, sia per principio che di fatto, a una rimemorazione che supera questa distanza, ma non l’annulla.
Il filosofo parla, ma è una sua debolezza, e una debolezza inspiegabile: egli dovrebbe tacere, coincidere in silenzio, e raggiungere nell’Essere una filosofia che vi è già fatta. Viceversa, tutto avviene come se egli volesse tradurre in parole un certo silenzio che è in lui e che egli ascolta. La sua intera “opera” è questo sforzo assurdo. Il filosofo scriveva per dire il suo contatto con l’Essere; ma non l’ha detto, e non potrebbe dirlo, giacché questo contatto è tacito.
esprime e decuplica quella delle cose nude. Il linguaggio è una vita, è la nostra vita e la loro. Non perché il linguaggio se ne impadronisca e se la riservi: che cosa avrebbe infatti da dire se ci fossero solo delle cose dette? L’errore delle filosofie semantiche consiste nel chiudere il linguaggio come se non parlasse che di sé: esso vive solamente del silenzio; tutto ciò che noi gettiamo agli altri ha germogliato in questo grande paese muto che non ci abbandona
qualsiasi esperienza è sempre contigua a una esperienza, che le nostre percezioni, i nostri giudizi, la nostra intera conoscenza del mondo possono essere mutati,
si vedrebbe infine che cos’è l’interrogazione filosofica. Non l’an sit, e il dubbio, dove l’Essere è sottinteso, e non l’”io so di non sapere niente”, in cui traspare già la certezza assoluta delle idee, ma un “che cosa so?” vero,
l’interrogativo non è un modo derivato per inversione o capovolgimento dell’indicativo e del positivo, né affermazione, né negazione velate o attese, ma un modo originale di aver di mira qualcosa, per così dire una domanda-sapere, che per principio non può essere superata da nessun enunciato o “risposta”, quindi, forse il modo proprio del nostro rapporto con l’Essere, come se esso fosse l’interlocutore muto o reticente delle nostre domande.
Il visibile attorno a noi sembra riposare in se stesso. È come se la nostra visione si formasse nel suo cuore, o come se fra noi e il visibile ci fosse una relazione altrettanto stretta che quella fra il mare e la spiaggia. E tuttavia, non è possibile che noi ci fondiamo con esso, né che esso passi in noi, altrimenti la visione svanirebbe al momento di realizzarsi, per scomparsa o del vedente o del visibile
lo spettacolo visibile appartiene al tatto né più né meno delle “qualità tattili”. Dobbiamo abituarci a pensare che ogni visibile è ricavato dal tangibile, ogni essere tattile è promesso in un certo qual modo alla visibilità;
Poiché il medesimo corpo vede e tocca, visibile e tangibile appartengono al medesimo mondo.
E un prodigio troppo poco notato il fatto che ogni movimento dei miei occhi - di più, ogni spostamento del mio corpo - ha il suo posto nel medesimo universo visibile che attraverso di essi io esploro nei suoi particolari, così come, reciprocamente, ogni visione si effettua in qualche luogo nello spazio tattile.
poiché la visione è palpazione con lo sguardo, occorre che anch’essa si inscriva nell’ordine d’essere che essa ci svela, occorre che colui che guarda non sia egli stesso estraneo al mondo che guarda.
Lungi dal rivaleggiare con lo spessore del mondo, quello del corpo è viceversa l’unico mezzo che io ho di andare al cuore delle cose, facendomi mondo e facendole carne.
Il corpo frapposto non è esso stesso cosa, materia interstiziale, tessuto connettivo, ma sensibile per sé, ciò che significa, non già questa assurdità: colore che si vede, superficie che si tocca, - ma questo paradosso [?]: un insieme di colori e di superfici abitati da un tatto, da una visione, dunque sensibile esemplare, che offre a chi l’abita e lo sente quanto occorre per sentire tutto ciò che all’esterno gli somiglia, cosicché, preso nel tessuto delle cose, egli lo trae tutto a sé, lo incorpora e, con lo stesso movimento, comunica alle cose sulle quali egli si chiude quella identità senza sovrapposizione, quella differenza senza contraddizione, quello scarto dell’interno e dell’esterno che costituiscono il suo segreto natale.
aperte solo a quello, se è possibile, che coesiste con esse nel medesimo mondo.
il nostro corpo è un essere a due fogli, da una parte cosa fra le cose e, dall’altra, ciò che le vede e le tocca; diciamo, poiché è evidente, che esso riunisce in sé queste due proprietà, e la sua doppia appartenenza all’ordine dell’”oggetto” e all’ordine del “soggetto” ci rivela relazioni molto insospettate fra i due ordini.
il corpo sentito e il corpo senziente sono come il diritto e il rovescio o, anche, come due segmenti di un unico percorso circolare che, in alto, va da sinistra a destra e, in basso, da destra a sinistra, ma che è un unico movimento nelle sue due fasi.
Il mio corpo come cosa visibile è contenuto nel grande spettacolo, ma il mio corpo vedente sottende questo corpo visibile, e tutti i visibili con esso. C’è inserimento reciproco e intreccio dell’uno nell’altro.
io mi sento guardato dalle cose, la mia attività è identicamente passività
Anche la stretta di mano è reversibile, io posso sentirmi toccato nella stessa misura e nello stesso tempo in cui mi sento toccante,
si rivolgono al corpo in generale e per se stesso (sia poi il mio o quello altrui), poiché per la prima volta, grazie all’altro corpo, io vedo che, nel suo accoppiamento con la carne del mondo, il corpo apporta più di quanto riceva, aggiungendo al mondo che io vedo il tesoro necessario di ciò che esso stesso vede.
affascinato dall’unica occupazione di fluttuare nell’Essere con un’altra vita, di divenire l’esterno del suo interno e l’interno del suo esterno. E perciò, movimento, tatto, visione, applicandosi all’altro e a se stessi, risalgono verso la loro sorgente e, nel lavoro paziente e silenzioso del desiderio, comincia il paradosso dell’espressione.
sono un essere sonoro, ma la mia propria vibrazione io la odo dall’interno;
fra di esse c’è sempre un “mosso”, uno “scarto”, è proprio perché le mie due mani fanno parte del medesimo corpo, perché esso si muove nel mondo, perché io mi odo e dall’interno e dall’esterno;
la Parola operante è la regione oscura dalla quale proviene la luce istituita, nello stesso modo in cui la sorda riflessione del corpo su se stesso è ciò che noi chiamiamo luce naturale.
Come c’è una reversibilità del vedente e del visibile, e come, nel punto in cui si incrociano le due metamorfosi, nasce ciò che si chiama percezione, così c’è una reversibilità della parola e di ciò che essa significa; la significazione è ciò che viene a sigillare, a chiudere, a raccogliere la molteplicità dei mezzi fisici, fisiologici, linguistici della elocuzione, a contrarli in un sol atto, nello stesso modo in cui la visione porta a compimento il corpo estesiologico;
non si può parlare né di distruzione né di conservazione del silenzio
la nostra esistenza di esseri sonori per gli altri e per se stessi, contengono tutto ciò che è richiesto perché dall’uno all’altro ci sia parola, parola sul mondo. E, in un certo senso, comprendere una frase non è altro che accoglierla pienamente nel suo essere sonoro, o, come si dice opportunamente, intenderla; il senso non è su di essa come il burro sulla tartina, come un secondo strato di “realtà psichica” estesa sul suono: esso è la totalità di ciò che è detto, l’integrale di tutte le differenziazioni della catena verbale, è dato con le parole in coloro che hanno orecchie per udire.
Il modo di interrogare prescrive un certo tipo di risposta, e fissarlo sin d’ora equivarrebbe a decidere della nostra soluzione.
Ciò che essa sarà, lo sapremo solo tentando.
noi ci poniamo in noi e nelle cose, in noi e nell’altro, nel punto in cui, per una specie di chiasma, diveniamo gli altri e diveniamo mondo.
Perché sussistano come individui, o almeno perché continuino a portare queste denominazioni generali, è necessario che esibiscano un dato numero di proprietà in un certo qual modo nucleari, che derivano l’una dall’altra e che, tutte insieme, emanano da questo individuo ciottolo, da questo individuo conchiglia, o, in generale, da ogni individuo dello stesso nome.
Essa è ob-jectum, vale a dire che si dispiega davanti a noi per una virtù sua, e proprio perché è raccolta in se stessa.
Forse la cosa non ha nessuna potenza propria e interna, ma è pur sempre vero che, perché essa possa farsi riconoscere da noi, perché non scompaia, perché noi possiamo parlare di cose, è necessario che le apparenze si comportino come se avessero un principio di unità interna.
Ogni negazione del mondo, ma anche ogni neutralità nei confronti dell’esistenza del mondo, impedisce che si colga il trascendentale.
parlo delle cose come se ciò non mettesse in questione il linguaggio!
Questo inconscio da cercare, non in fondo a noi, dietro la nostra “coscienza”, ma davanti a noi, come articolazioni del nostro campo. Esso è “inconscio” per il fatto che non è oggetto, ma è ciò grazie a cui degli oggetti sono possibili, è la costellazione in cui si legge il nostro avvenire - L’inconscio è fra di essi come l’intervallo degli alberi fra gli alberi, o come il loro livello comune.
nel visibile non ci sono mai se non delle rovine dello spirito, il mondo somiglierà sempre al Foro, per lo meno nei confronti del filosofo, che non lo abita completamente
Dire che c’è trascendenza, essere a distanza, equivale a dire che l’essere (nel senso sartriano) è talmente gonfiato di non-essere o di possibile che esso non è solamente ciò che è.
il pre-scientifico non è se non invito a comprendere il meta-scientifico, e quest’ultimo non è non-scienza. Esso è anzi svelato dai procedimenti costitutivi della scienza, a condizione che li si riattivi, che si veda ciò che essi verdecken lasciati a se stessi.
La contraddizione è rimossa solo se il nuovo presente è esso stesso un trascendente: si sa che esso non è qui, che è appena stato qui, non si coincide mai con esso - Esso non è un segmento di tempo dai contorni definiti che verrebbe a mettersi a posto.
il mondo non è né finito né infinito, ma indefinito
la verità stessa non ha alcun senso fuori del rapporto di trascendenza,
Non siamo noi a percepire, è la cosa a percepirsi laggiù, - non siamo noi a parlare, è la verità a parlarsi in fondo alla parola - Divenire natura dell’uomo che è il divenire uomo della natura - Il mondo è campo, e a questo titolo sempre aperto
Lo si vede se si arriva a fare della filosofia una percezione, e della storia della φ una percezione della storia - Tutto si riduce a ciò: elaborare una teoria della percezione e della comprensione che dimostri che comprendere non è costituire nell’immanenza intellettuale, che comprendere è cogliere per coesistenza, lateralmente, come stile, e con ciò raggiungere di colpo le lontananze di questo stile e di questo apparato culturale.
c’è germinazione di ciò che sta per essere stato compreso (Insight e Aha Erlebnis) - E ciò significa: la percezione (la prima) è dì per sé apertura di un campo di Gestaltungen - E ciò significa: la percezione è inconscio.
Che cos’è l’inconscio? Ciò che funge da cardine, esistenziale, e, in questo senso, è e non è percepito. Infatti non percepiamo che figure su livelli - E le percepiamo solo in rapporto al livello, che dunque è impercepito. - La percezione del livello: sempre fra gli oggetti, esso è ciò attorno a cui…
Il suo schema corporeo è per sé-per altri - E la cerniera del per sé e del per altri - Avere un corpo significa essere guardati (non è soltanto questo), significa essere visibili - Qui l’impressione di telepatia, d’occulto = vivacità nella lettura fulminea dello sguardo altrui - Si deve dire lettura? È viceversa in virtù di questo fenomeno che si comprende la lettura
I sensi sono apparati atti a realizzare delle concrezioni di ciò che è inesauribile, a formare dei significati esistenti - Ma la cosa non è veramente osservabile: in ogni osservazione c’è sempre un differimento, non si è mai alla cosa stessa.
L’autore si riferisce a questo passo: “Ma questa durata, che la scienza elimina, che è difficile concepire ed esprimere, la si sente e la si vive. Se cercassimo quello che essa è? In che modo apparirebbe a una coscienza che voglia solo vederla senza misurarla, che la colga quindi senza fermarla, che infine assuma se stessa come oggetto e che, spettatrice e attrice, spontanea e riflessa, avvicini sino a farli coincidere insieme l’attenzione che si fissa e il tempo che fugge?” La Pensée et le Mouvant,
E cioè che le cose ci possiedono, e che non siamo noi a possederle. Che l’essere che è stato non può cessare di essere stato. La “Memoria del Mondo”. Che il linguaggio ci possiede e non siamo noi a possederlo. Che è l’essere a parlare in noi e non noi a parlare dell’essere.
La soluzione va cercata nella visione stessa: non si comprenderà il ricordo se non attraverso quest’ultima.
Si deve passare dalla cosa (spaziale o temporale) come identità, alla cosa (spaziale o temporale) come differenza, i.e. come trascendenza, i.e. come sempre “dietro”, al di là, lontana…
l’arte e la filosofia insieme sono appunto non fabbricazioni arbitrarie nell’universo dello “spirituale” (della “cultura”), ma contatto con l’Essere proprio in quanto creazioni.
L’Essere è ciò che esige da noi creazione affinché ne abbiamo l’esperienza. Fare analisi della letteratura in questo senso: come inscrizione dell’Essere.
Nell’ordine del sottinteso, la ricerca dell’essenza e quella dell’esistenza non sono contrapposte, sono la stessa cosa - Considerare il linguaggio, anche filosofico, non come somma di enunciati o di “soluzioni”, ma come un velo sollevato, una catena verbale intrecciata…
La vera filosofia = cogliere ciò che fa sì che l’uscire da sé sia rientrare in sé e viceversa. Cogliere questo chiasma, questo rivolgimento. Ecco lo spirito.
una filosofia è un oggetto che può suscitare più pensieri di quanti ne “contenga”
Ma il cubo stesso in opposizione alle prospettive, - è una determinazione negativa. L’Essere è qui ciò che esclude ogni non-essere, ogni apparenza; l’in sé è ciò che non è semplicemente percipi. Lo spirito come portatore di questo Essere è ciò che non è in nessun luogo, ciò che avvolge ogni dove
dunque la riflessione non è identificazione a sé (pensiero di vedere o di sentire) ma non-differenza con sé = identificazione silenziosa o cieca.
Lasciate a se stesse, le regioni della conoscenza sono in conflitto e in contraddizione.
per un autentico mistero (Leibniz), i possibili non sono compossibili.
Se l’essere deve svelarsi, lo farà di fronte a una trascendenza, e non di fronte a una intenzionalità, sarà l’essere grezzo affondato che ritorna a se stesso, sarà il sensibile che si scava –
Noi sogniamo dei sistemi di equivalenze, ed effettivamente essi funzionano. Ma la loro logica, come quella di un sistema fonematico, è riassunta in un solo ciuffo, in una sola gamma, essi sono tutti animati da un solo movimento, sono ciascuno e tutti un solo vortice, un solo recesso dell’Essere. Occorre esplicitare questa totalità d’orizzonte che non è sintesi
La chiave è nell’idea che la percezione è di per sé ignoranza di sé come percezione selvaggia, impercezione, tende di per sé a vedersi come atto e a dimenticarsi come intenzionalità latente, come inerire a – Stesso problema: come ogni φ sia linguaggio e come consista però nel ritrovare il silenzio.
Non c’è mondo intelligibile, c’è mondo sensibile.
tra la percezione e il linguaggio c’è pur sempre questa differenza: che io vedo le cose percepite e che viceversa i significati sono invisibili. L’essere naturale è in riposo in se stesso, il mio sguardo può fermarsi su di esso. L’Essere di cui il linguaggio è la dimora non può essere fissato, guardato, non è se non da lontano
Il sensibile è ciò: questa possibilità di essere evidente in silenzio, di essere sottinteso; e la pretesa positività del mondo sensibile (quando la si scruta sin nelle sue radici, quando si va oltre il sensibile-empirico, il sensibile secondo della nostra “rappresentazione”, quando si svela l’Essere della Natura) dimostra appunto di essere un inafferrabile;
Il senso è invisibile, ma l’invisibile non è il contrario del visibile: il visibile ha esso stesso una membratura di invisibile, e l’in-visibile è la contropartita segreta del visibile, non appare che in esso, è il Nichturpräsentierbar che mi viene presentato come tale nel mondo - non si può vedervelo, e ogni sforzo per vedervelo lo fa scomparire, ma esso è nella linea del visibile, ne è il fuoco virtuale, si inscrive in esso (in filigrana) –
ὁμοῦ ἦν πάντα
Ogni “senso” è un “mondo”, i.e. assolutamente incomunicabile per gli altri sensi, e nondimeno costruisce un qualcosa che, per la sua struttura, sbocca immediatamente nel mondo degli altri sensi e forma con essi un sol Essere.
Il “Mondo” è quell’insieme in cui ogni “parte”, quando la si prende per se stessa, apre di colpo delle dimensioni illimitate, - diviene parte totale.
quell’Essere che è fra la mia prospettiva e quella altrui, fra il mio passato e il mio presente. La peculiarità del percepito: essere già qui, non essere grazie all’atto di percezione, essere la ragione di questo atto, e non l’inverso. La sensorialità = la trascendenza, o uno specchio della trascendenza
E dunque la profondità a far sì che le cose abbiano una carne: e cioè oppongano alla mia ispezione degli ostacoli, una resistenza che è appunto la loro realtà, la loro “apertura”, il loro totum simul. Lo sguardo non vince la profondità, l’aggira.
Profonda parentela fra l’essenza e la percezione: anche l’essenza è membratura, non è al di sopra del mondo sensibile, è al di sotto, o nella sua profondità, nel suo spessore. Essa è il legame segreto - le Essenze sono degli Etwas del livello della parola, così come le cose sono delle Essenze del livello della Natura.
non sono io a farmi pensare più di quanto sia io a far battere il mio cuore.
Una “direzione” di pensiero - Non è una metafora - Non c’è metafora fra il visibile e l’invisibile (l’invisibile: o il mio pensiero per me, o il sensibile dell’altro per me): metafora, è troppo o troppo poco: troppo se l’invisibile è veramente invisibile, troppo poco se esso si presta alla trasposizione
Una direzione non è nello spazio: è in filigrana attraverso di esso - Essa è dunque trasferibile al pensiero –
Un “mondo” (è tutto un mondo, il mondo del suono, del colore, ecc..) = un insieme organizzato, che è chiuso, ma che, stranamente, è rappresentativo di tutto il resto, possiede i suoi simboli, i suoi equivalenti per tutto ciò che è altro da sé.
Un “mondo” ha delle dimensioni. Per definizione esse non sono le uniche possibili (passando a una 3a dimensione, degli esseri spaziali separati nelle prime due possono essere collegati). Ma per definizione esse hanno altresì valore di membratura, sono più che singolarità di contenuto:
il mondo delle idee si prolunga nel linguaggio (lo si pensa) che reciprocamente si prolunga nelle idee (si pensa perché si parla, perché si scrive) Le parole degli altri mi fanno parlare e pensare perché creano in me un altro da me, uno scarto in rapporto a… ciò che io vedo e così me lo designano a me stesso. Le parole dell’altro formano la trama attraverso la quale io vedo il mio pensiero.
Vedere non è vedere - vedere l’altro è essenzialmente vedere il mio corpo come oggetto, di modo che il corpo oggetto dell’altro possa avere un “lato” psichico. L’esperienza del mio corpo e quella dell’altro sono esse stesse i due lati di un medesimo Essere: dove dico che vedo l’altro, in verità accade soprattutto che io oggettivo il mio corpo, l’altro è l’orizzonte o l’altro lato di questa esperienza - E così che si parla all’altro quantunque si abbia a che fare solo con se stessi).
La trascendenza è l’identità nella differenza.
Si fa un passo avanti sopprimendo l’In sé modello:
Principio: non considerare l’invisibile come un altro visibile “possibile”, o un “possibile” visibile per un altro: ciò equivarrebbe a distruggere la membratura che ci congiunge a esso. Del resto, poiché quest’”altro” che lo “vedrebbe”, - o quest’”altro mondo” che esso costituirebbe, sarebbe necessariamente collegato al nostro, la possibilità vera riapparirebbe necessariamente in questo collegamento - L’invisibile è qui senza essere oggetto, è la trascendenza pura, senza maschera ontica. E in fin dei conti anche i “visibili” stessi sono solo centrati su un nucleo d’assenza –
Quando io mi muovo, le cose percepite hanno uno spostamento apparente che è inversamente proporzionale alla loro distanza - le più vicine si muovono di più - L’ampiezza dello spostamento può servire da indice alla distanza.
la struttura del campo visivo è indispensabile perché vi sia trascendenza, il modello di ogni trascendenza.
Il legame fra l’anima e il corpo non è più parallelismo (e in definitiva identità in un Essere infinito ob-iettivo di cui la totalità del corpo e la totalità dell’anima sono due espressioni), - e non è nemmeno opacità assoluta di una istituzione che collega per efficacia [decisoria?] 2 ordini, ciascuno dei quali sarebbe autosufficiente - Esso è da comprendere come legame del convesso e del concavo, della volta solida e della cavità che essa forma - Nessuna corrispondenza (parallelistica o di puro occasionalismo) è da cercare fra ciò che avviene “nel corpo” e ciò che avviene “nell’anima” nella percezione: è il medesimo controsenso in cui si cadrebbe se si cercasse nel mondo fisico un equivalente esatto degli organismi o negli organismi una spiegazione microcausale integrale - L’anima è conficcata nel corpo come il paletto nel terreno, senza corrispondenza puntuale fra terreno e paletto, - o meglio: l’anima è la cavità del corpo, il corpo è il rigonfiamento dell’anima. L’anima aderisce al corpo come la loro significazione aderisce alle cose culturali di cui è il rovescio o l’altro lato –
La sensibilità degli altri è “l’altro lato” del loro corpo estesiologico
L’accoppiamento dei corpi, vale a dire la convergenza delle loro intenzioni verso una sola Erfüllung, verso un solo muro contro il quale essi si scontrano da due parti, è latente nella considerazione di un unico mondo sensibile, al quale tutti possono partecipare, che è dato a ognuno.
perché io non mi ignori, è necessario che un corpo percepisca i corpi
nella struttura universale “mondo”, - sopravanzamento di tutto su tutto, essere di promiscuità, - che si trova il serbatoio dal quale proviene questa nuova vita assoluta. Ogni verticalità deriva dall’Essere verticale –
Ci si deve abituare a comprendere che il “pensiero” (cogitatio) non è contatto invisibile di sé con sé, che esso vive fuori di questa intimità con se stesso, davanti a noi, non in noi, sempre eccentrico.
si deve ritrovare come realtà del mondo interumano e della storia una superficie di separazione fra me e l’altro che è anche il luogo della nostra unione, l’unica Erfüllung della sua vita e della mia vita. E verso questa superficie di separazione e di unione che procedono gli esistenziali della mia storia personale, essa è il luogo geometrico delle proiezioni e delle introiezioni, è il cardine invisibile sul quale la mia vita e quella degli altri ruotano per precipitare l’una nell’altra, la membratura dell’intersoggettività
L’idea cartesiana del corpo umano in quanto umano non chiuso, aperto in quanto governato dal pensiero, - è forse la più profonda idea dell’unione dell’anima e del corpo. L’anima interviene dunque in un corpo, il quale non è un che di in sé (se lo fosse, esso sarebbe chiuso come un corpo animale) e può essere corpo e vivente-umano solo compiendosi in una “visione di sé” che è il pensiero
l’invisibile è una cavità nel visibile, una piega nella passività, non produzione pura.
Per studiare l’inserimento di tutte le dimensionalità nell’Essere, - studiare l’inserimento della profondità nella percezione, e quello del linguaggio nel mondo del silenzio – Mostrare che non c’è variazione eidetica senza parola; mostrarlo a partire dall’ immaginario come sostegno della variazione eidetica, e dalla parola come sostegno dell’immaginario PROBLEMA DEL NEGATIVO E DEL CONCETTO
Per studiare l’inserimento di tutte le dimensionalità nell’Essere, - studiare l’inserimento della profondità nella percezione, e quello del linguaggio nel mondo del silenzio – Mostrare che non c’è variazione eidetica senza parola; mostrarlo a partire dall’ immaginario come sostegno della variazione eidetica, e dalla parola come sostegno dell’immaginario
Per me, il negativo non vuol dire assolutamente nulla, e nemmeno il positivo (essi sono sinonimi) e questo non per appello a un vago “miscuglio” dell’essere e del nulla, la struttura non è “miscuglio”.
Noi siamo nell’umanità come orizzonte dell’Essere, poiché l’orizzonte è ciò che ci circonda, noi non meno che le cose. Ma è l’orizzonte, non l’umanità, che è l’essere
per me la verità è quell’ai di là della verità, quella profondità in cui ci sono ancora parecchi rapporti da considerare.
concetto, il significato sono il singolo dimensionalizzato, la struttura formulata, e non c’è visione di questo cardine invisibile; il nominalismo ha ragione: i significati non sono altro che scarti definiti
siamo un campo d’Essere. Anche nel presente il paesaggio è configurazione.
non c’è associazione che agisca se non quando c’è sovradeterminazione, cioè un rapporto di rapporti, una coincidenza che non può essere fortuita, che ha senso ominale.
il passato è “simultaneo” con il presente in senso ristretto.
Ci si sente guardati (bruciore della nuca) non perché qualcosa passi dallo sguardo al nostro corpo e venga a bruciarlo al punto visto, ma perché sentire il proprio corpo è anche sentire il suo aspetto per l’altro.
Il mondo percepito (come la pittura) è l’insieme delle vie del mio corpo, e non una moltitudine di individui spazio-temporali - L’invisibile del visibile.
vedere è quella specie di pensiero che non ha bisogno di pensare per possedere il Wesen -
il mio corpo è fatto della medesima carne del mondo (è un percepito), e che, inoltre, di questa carne del mio corpo è partecipe il mondo, esso la riflette, il mondo sopravanza su di essa ed essa sopravanza sul mondo (il sentito saturo di soggettività e al tempo stesso di materialità), essi sono in rapporto di trasgressione o di sopravanzamento - Ciò vuole anche dire: il mio corpo non è soltanto un percepito fra i percepiti, è misurante82 di tutti, Nullpunkt di tutte le dimensioni del mondo.
l’esperienza che io ho di me percipiente non va al di là di una specie di imminenza, termina nell’invisibile: semplicemente questo invisibile è il suo invisibile,
il sensibile è, come la vita, un tesoro sempre pieno di cose da dire per chi è filosofo (cioè scrittore).
questo invisibile attesta appunto che Wahrnehmen è Sich bewegen, c’è qui un successo nel fallimento. Wahrnehmen non riesce a cogliere Sich bewegen (e io sono per me zero di movimento anche nel movimento, non mi allontano da me) proprio perché essi sono omogenei e tale fallimento è la prova di questa omogeneità: Wahrnehmen e Sich bewegen emergono l’uno dall’altro. Specie di riflessione per E-stasi, essi sono il medesimo ciuffo.
Toccare è toccarsi. Da intendere come: le cose sono il prolungamento del mio corpo e il mio corpo è il prolungamento del mondo, grazie a esso il mondo mi circonda - Se io non posso toccare il mio movimento, questo movimento è interamente intessuto di contatti con me - Si deve intendere il toccarsi e il toccare come rovescio l’uno dell’altro
Il movimento proprio, attestazione di una cosa-soggetto: movimento come delle cose, ma movimento che io faccio Partire da qui per comprendere il linguaggio come fondamento dell’io penso: esso è per l’io penso ciò che il movimento è per la percezione.
L’invisibile è 1) ciò che non è attualmente visibile ma potrebbe esserlo (aspetti nascosti o inattuali della cosa, - cose nascoste, situate “altrove” -”Qui” e “altrove”) 2) ciò che, relativo al visibile, non potrebbe però essere visto come cosa (gli esistenziali del visibile, le sue dimensioni, la sua membratura non figurativa) 3) ciò che esiste solo tattilmente o cinestesicamente ecc. 4) i λεχτά, il Cogito Questi 4 “strati” io non li riunisco logicamente sotto la categoria dell’ in-visibile Ciò è impossibile anzitutto per la semplice ragione che, poiché il visibile non è un positivo oggettivo, l’invisibile non può essere una negazione in senso logico – Si tratta di una negazione-riferimento (zero di…) o scarto. Questa negazione-riferimento è comune a tutti gli invisibili perché il visibile è stato definito come dimensionalità dell’Essere, i.e. come universale, e perché quindi tutto ciò che non ne fa parte è necessariamente avvolto in esso e non è che modalità della medesima trascendenza.
Your Highlight on Location 4952-4953 | Added on Monday, August 18, 2025 10:21:11 AM
Your Highlight on Location 4964-4971 | Added on Monday, August 18, 2025 10:23:22 AM
Your Highlight on Location 5001-5003 | Added on Monday, August 18, 2025 10:27:25 AM
Your Highlight on Location 5004-5005 | Added on Monday, August 18, 2025 10:27:31 AM
Your Highlight on Location 5007-5007 | Added on Monday, August 18, 2025 10:27:53 AM
Your Highlight on Location 5019-5022 | Added on Monday, August 18, 2025 10:29:27 AM
Your Highlight on Location 5085-5087 | Added on Monday, August 18, 2025 3:28:28 PM
Your Highlight on Location 5198-5206 | Added on Monday, August 18, 2025 7:02:25 PM
Your Bookmark on Location 5469 | Added on Monday, August 18, 2025 7:28:32 PM
Your Highlight on Location 5493-5495 | Added on Monday, August 18, 2025 7:30:32 PM
Your Highlight on Location 5538-5541 | Added on Tuesday, August 19, 2025 7:45:26 AM
Your Highlight on Location 5554-5559 | Added on Tuesday, August 19, 2025 7:47:41 AM
Your Highlight on Location 5574-5578 | Added on Tuesday, August 19, 2025 7:50:12 AM
Your Highlight on Location 5582-5587 | Added on Tuesday, August 19, 2025 7:51:30 AM
Your Highlight on Location 5619-5620 | Added on Tuesday, August 19, 2025 7:55:39 AM